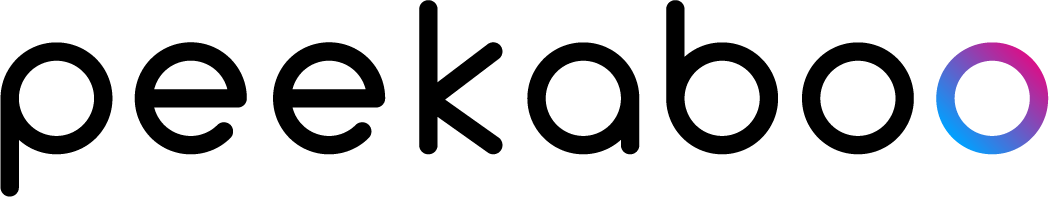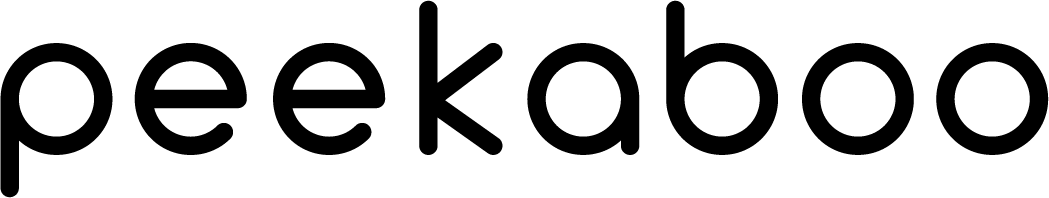Fenomenologia della Disruptive Innovation: romantico ritorno al significato originale.
Tempo di lettura: 3 min
C’è una parola che amo e che a mio avviso ha un fascino immenso quando associata all’universo dell’innovazione: Disruptive.
Questa parola è talmente bella che è in grado di riassumere in sole 10 lettere, intere disquisizioni e teorie sull’innovazione.
E’ una parola “potente” e come tale va maneggiata con cura. Va utilizzata con il contagocce perché si riferisce ad eventi che accadono raramente.
Perché questa introduzione?
Perché oggi ogni volta che la sento mi si spezza il cuore. Ormai è un anno che porto il cappello da VC e ogni volta che entro in contatto con imprenditori e innovatori, questa parola inevitabilmente esce fuori ed io puntualmente ribalto gli occhi all’indietro.
“Abbiamo una tecnologia disruptive”
“Il nostro disruptive business rivoluzionerà il mercato”
Ora non sto qui a sminuire gli startupper, gli inventori, gli imprenditori, i visionari e i manager con cui entro in contatto quotidianamente.
Di idee belle se ne vedono molte, e di imprenditori visionari e “cazzuti” ce ne sono eccome, per fortuna. Giù il cappello di fronte a chi innova, perché chi ha il coraggio di farlo, lo fa perché ha visto delle cose che evidentemente non gli andavano bene, ed allora innova mosso dalla volontà di cambiarle.
Il problema di cui mi lamento è che l’universo startup ha preso questa fantastica parola e l’ha svuotata senza pietà del suo purissimo e sottile significato.
Disruptive è diventato un cliché usato per descrivere qualsiasi tipo di sforzo volto a cambiare, possibilmente in meglio, il proprio business o un’intera industry.
Ma facciamo un passo indietro.
Quando è stato coniato per la prima volta il termine Disruptive Innovation?
Nel 1995, da Clayton Christensen, che ho avuto la fortuna di vedere e sentire parlare dal vivo, e vi posso giurare che lui si che è un fuoriclasse dell’innovazione.
Bene, nel 1995, Christensen, insieme a Joseph Bower, pubblicò un articolo intitolato “Disruptive Technologies: Catching the Wave“. La domanda alla base dello studio di Christensen non era esattamente banale: perché le smart companies falliscono?
Questo articolo è stato il filo conduttore del celebre libro che scrisse nel 1997 e che oggi molti manager (forse per sentirsi in pace con la coscienza) tengono sulla scrivania: “The Innovator’s Dilemma“.
L’idea di base è che le grandi corporation investono la maggior parte del proprio tempo e delle proprie risorse in innovazioni di tipo “sustaining”, che generano migliorie di prodotto incrementali partendo da tecnologie di cui già dispongono.
Questi soggetti spesso stanno alla larga da tutto ciò che invece è innovazione radicale per ovvi rischi annessi a tecnologie che magari mai verranno accettate dal mercato.
Inoltre, le innovazioni di tipo radicale, soprattutto inizialmente, non s’incarnano in nuove spettacolari tecnologie ma spesso evolvono da sottostimate tecnologie già esistenti (spesso sviluppate dalle stesse big companies, vedi Kodak e la fotografia digitale) le cui performance generalmente sono molto scarse.
Ed è questa la parte romantica della faccenda.
Questo tipo d’innovazioni, è quello in cui sguazzano tipicamente le startup, che, sfruttando anche la propria struttura snella, creano nuovi prodotti destinati a una nicchia di customers avidi d’innovazione (early adopters).
Le Big companies continuano per la loro strada finché si accorgono che qualcosa è cambiato, e generalmente è troppo tardi per rimediare all’errore. Infatti, nella loro miopia da incumbent si sono talmente tanto preoccupati di erigere mura e bastioni intorno al loro core business, che non si sono accorti di aver perso completamente la propria market share.
Questa perdita di controllo sul mercato non è dovuta ad un nuovo terrificante competitor, ma al fatto che l’intero mercato è cambiato.
La competition si è totalmente spostata su un piano diverso.
Ed è proprio questo il punto, quando una tecnologia è realmente disruptive, innesca un terremoto che rivoluziona l’intero paradigma tecnologico in cui è nata. Ne cambia l’essenza stessa.
Crea un periodo “fluido” e confuso in cui emergono tante tecnologie alternative che risolvono lo stesso need in vari nuovi modi. Questi periodi si superano soltanto abbandonando la visione preesistente secondo la quale un dato need si può risolvere in un dato modo solo perché lo si è sempre fatto così.
Si deve ampliare la propria visione tecnologica, assimilare i nuovi input ed andare avanti col progresso.
Ad esempio, reinterpretando e adattando allo sviluppo tecnologico un concetto che ho trovato nel meraviglioso libro “Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta”, non possiamo pensare che l’esplorazione della Luna sia un evento disruptive.
Sicuramente è stato di grande importanza per l’umanità, ma già si sapeva che si sarebbe potuto fare e non ha rivoluzionato schemi e conoscenze preesistenti. E’ un evento di tipo incrementale, per dirla nel gergo di Christensen.
Il viaggio di Cristoforo Colombo con annessa scoperta dell’America, quello si che è disruptive, perché implicò un radicale ampliamento della conoscenza umana.
Nessuno pensava si potesse fare, nessuno pensava che la Terra non fosse piatta.
Così, spostandoci a temi più attuali e più caldi, sarebbe realmente disruptive la missione StarShot pianificata da Stephen Hawking, Mark Zuckerberg e Yuri Milner per raggiungere la stella più vicina al sole: Alpha Centauri.
Con le tecnologie di oggi e con i nostri pre-esistenti schemi tecnologici e mentali sarebbe praticamente impossibile. Ci vorrebbero infatti circa 30.000 anni per raggiungere Alpha Centauri, mentre invece StarShot prevede di arrivarci in appena 20 anni.
C’è una sola parola che può definire un tale progresso tecnologico, che nessuno (se non pochi pazzi visionari) ritiene possibile; una sola, fantastica, parola che racchiude in se stessa magia e stupore assimilabile solo a qualcosa di grandioso.
Dieci lettere: DISRUPTIVE.
Tornando ai miei ribaltamenti di occhi, questi son dovuti al fatto che oggi “disruptive” è diventato parte del gergo imprenditoriale.
Molti imprenditori lo usano quando semplicemente creano un prodotto o servizio migliore di uno esistente, molti altri invece lo usano come parola magica per far colpo sui VC, sugli Angels o sulla platea di innovatori in modo da far vedere che in un certo senso sono diversi o innovativi.
Il che è possibile, non è detto che effettivamente non siano innovativi.
Semplicemente non sono così disruptive come credono di essere o vogliono fare credere di essere.
Articolo a cura di Alessandro Petrich